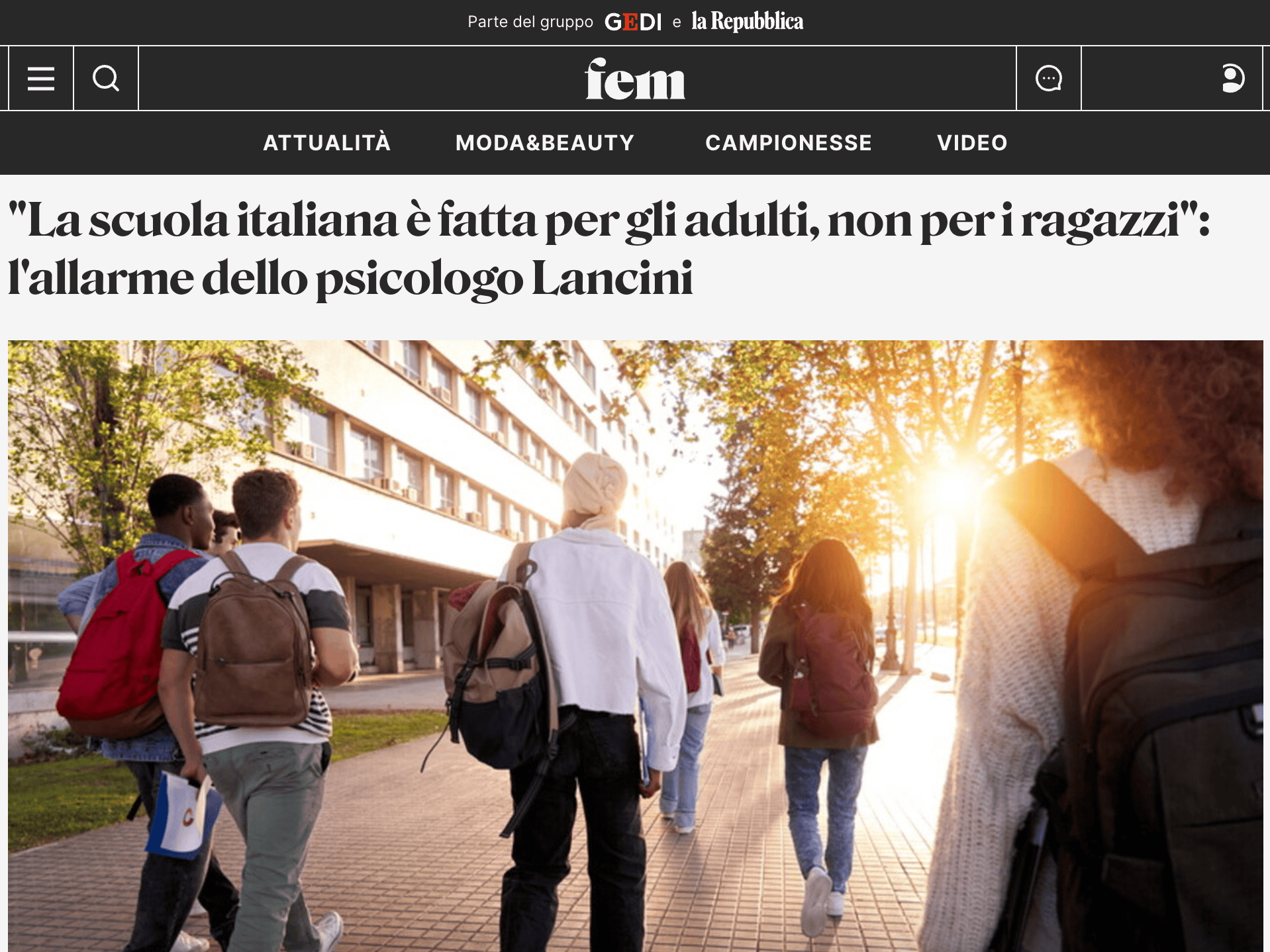“La scuola italiana è fatta per gli adulti, non per i ragazzi”: l’allarme dello psicologo Lancini
Lo psicoterapeuta Matteo Lancini analizza la crisi dell’autorevolezza adulta. Gli adolescenti italiani devono farsi carico della fragilità di genitori e insegnanti che respingono le emozioni “negative” dei ragazzi mentre professano di amarli. La scuola perpetua un modello obsoleto che ignora l’intelligenza artificiale e demonizza la tecnologia usata quotidianamente dagli stessi adulti, alimentando una pericolosa frattura tra generazioni.
Genitori e insegnanti inermi e confusi, adulti più spaventati degli adolescenti della relazione (mancata) con figli e alunni. “In Adolescence non ci sono adulti significativi e autorevoli, ma solo adulti alla ricerca di colpevoli, impegnati a zittire il chiasso più che a capirne le ragioni. È il problema della società e molto spesso della scuola odierna”, spiega Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, docente alla Statale di Milano e presidente della fondazione Minotauro di Milano, che ne parla anche nel suo ultimo libro Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti. Nella ormai celeberrima serie la figura dell’adulto ne esce povera, sconfitta e inerme. E quella della scuola anche.
Una scuola non pronta ad affrontare il disagio adolescenziale
Professor Lancini, la serie “Adolescence” mostra una grande difficoltà della scuola, nella figura degli insegnanti, a gestire e “tenere” i ragazzi. La situazione nelle scuole secondarie italiane è simile?
“Lavoro con la scuola da 32 anni e bisogna innanzitutto capire di quale scuola parliamo. In Italia abbiamo circa 41 mila istituti scolastici, con un milione e duecentomila dipendenti del ministero – credo sia l’industria più grande d’Europa. Se lei entrasse in cinque diversi licei classici di Milano, scoprirebbe cinque mondi completamente diversi, perché un’istituzione così fatta di persone dipende dalla storia di quell’istituto, dagli avvenimenti significativi, dai dirigenti scolastici, da mille fattori diversi”.
Quali sono i problemi principali?
“La scuola italiana da diverso tempo sa cosa dovrebbe fare, ma non succede, e questa è una delle situazioni più difficili. È una scuola che non è organizzata per i bambini né per gli studenti, cioè per i minorenni in Italia che non votano, ma è una scuola organizzata per gli adulti: i suoi dipendenti e i genitori che continuano a dire, nonostante sia cambiato tutto, ‘ai miei tempi la scuola non ha mai fatto male a nessuno, un 4, un 5, una bocciatura’. Nel frattempo però è cambiato tutto”.
Perché è così difficile cambiare il sistema scolastico italiano?
“Tutti i politici di destra, sinistra, centrosinistra, centrodestra, sindacalisti e dirigenti scolastici sanno benissimo che chi tocca la scuola italiana ha già perso le elezioni. Il ministero dell’istruzione – che ai miei tempi si chiamava della pubblica istruzione, oggi si chiama dell’istruzione e del merito – dovrebbe essere il più importante in Italia, ma viene considerato un ministero di serie C. Gran parte delle risorse deve spenderle per tenere a bada gli adulti, non per i ragazzi”.
Il divario tra la scuola e il mondo contemporaneo
In che modo la scuola è inadeguata rispetto alle esigenze attuali?
“È una scuola che non riesce ad adattarsi a quello che servirebbe. Non dovrebbe essere più organizzata sulle singole materie – sono cose che si sanno da vent’anni. Le materie non sono state date da Dio a Mosè sul Monte Sinai. Durante la scolarizzazione di massa abbiamo dovuto dividere il sapere in modo arbitrario: chimica, fisica, matematica. Con l’arrivo di internet, tutti i ricercatori sanno che bisognerebbe smettere di fare riunioni per discipline e studiare per materie, perché l’essere umano è fatto per l’interdisciplinarietà. Ma se tocchi le materie, crolla il sistema”.
Come questo influisce sulla valutazione?
“Si sa che le bocciature stanno aumentando la dispersione scolastica. Esistono sistemi di valutazione non numerici che sarebbero più utili, ma richiederebbero sforzo. La scuola italiana oggi non favorisce l’apprendimento, ma la competizione a partire dalla primaria. Dà bollini rossi e verdi, dicendo che lo fa per i ragazzi, ma in realtà lo fa perché così gli adulti sentono di avere il controllo. È una scuola che dovrebbe smetterla di interrogare sulle competenze e le nozioni a memoria”.
Cosa servirebbe invece?
“Nessuno da tempo sa che quello che serve è sapere le materie a memoria. Questo funzionava ai tempi di mia nonna, che era una maestra di paese quando nessuno aveva l’enciclopedia Treccani e quindi dovevi detenere il sapere. Mio padre ancora ricorda tutto del liceo, io già meno. Perché? Perché il sistema attuale ha creato una serie di informazioni o nozioni che puoi trovare e discutere facilmente. Quindi bisognerebbe insegnare non tanto a rispondere alle domande, ma a fare le domande giuste – soprattutto con l’arrivo dell’intelligenza artificiale”.
Il paradosso della tecnologia a scuola
C’è una contraddizione nell’approccio alla tecnologia?
“La scena più drammatica della nostra vita avviene a giugno durante gli esami di maturità, quando degli adulti perquisiscono dei diciottenni, non chiedendo scusa per non farli fare una prova con internet aperto e usando l’intelligenza artificiale, come fanno ormai insegnanti in tutta Europa e anche in Italia. Li perquisiscono come se fossero delinquenti perché hanno il cellulare in una società che vive online. Chiedo da tempo che almeno alla maturità ci sia l’open internet, ma non viene fatto”.
In Adolescence mancano adulti significativi. È così anche nella realtà?
“Nella serie, come a scuola e anche in famiglia, non esiste un adulto significativo. Anzi, sono i ragazzi, compresi quelli che hanno commesso reati o quelli imbarazzati, come il figlio del poliziotto, che devono prendersi carico della fragilità degli adulti, esattamente come fanno tutti i figli e gli studenti oggi quando vanno a scuola”.
Esempi virtuosi (che esistono già)
Ci sono insegnanti che stanno già cambiando approccio?
“Sì, molti lo fanno. Gli insegnanti più bravi d’inglese, anche in Italia, sono tre anni che non fanno altro che compiti in classe con l’intelligenza artificiale. Mentre il ministero parla di 15 classi che stanno sperimentando l’intelligenza artificiale, ci sono insegnanti che da tempo danno il voto solo alla fine dell’anno. Si chiamano scuole delle relazioni e delle responsabilità, dove la valutazione è serissima e rigorosa, non come chi dà voti senza spiegare e alimenta solo la competizione”.
Cosa fanno questi insegnanti di diverso?
“Usano l’intelligenza artificiale, si fanno fare le domande, danno valutazioni non numeriche, ma qualitative. Per l’autonomia scolastica, lo possono fare tutte le scuole – l’importante è dare il voto alla fine dell’anno. È pieno di docenti che fanno co-costruire il sapere. Il problema è che è impossibile mettere a regime questi sistemi, perché anche i dirigenti che provano a portarli avanti subiscono attacchi furenti dalle istituzioni”.
Quanto è grave la situazione attuale?
“Questi docenti innovatori sono gli unici che stanno tentando di non far chiudere la scuola italiana, perché qui stiamo scherzando col fuoco. Lavoro in un centro che da 40 anni si occupa del disagio giovanile e non c’era mai successo che due richieste su tre fossero di ragazzi intelligenti, prevalentemente maschi, che non vogliono più andare a scuola. A volte sanno tre lingue e non studiano più. In questo momento la scuola italiana sta affrontando un esodo di adolescenti”.
La fragilità emotiva degli adulti e il suo impatto sui giovani
Come si riflette la fragilità degli adulti sui ragazzi?
“Abbiamo ragazzi che hanno dovuto prendersi in carico della fragilità di padri, madri, insegnanti, che sostengono che li ascoltano di più rispetto al passato. E in effetti la famiglia odierna ascolta di più anche rispetto alla scuola, ma abbiamo costruito un patto terribile con i nostri figli: diciamo che li ascoltiamo di più, che li abbiamo voluti, ma questo patto lo rompiamo nel momento esatto in cui iniziano ad esprimere parti di sé che ci danno fastidio”.
Quali sono le emozioni che vengono represse?
“Non certo quando uno è contento, studia o va a fare sport, ma quando prova tristezza, paura, rabbia. Queste emozioni vengono messe a tacere completamente da papà, mamma e insegnanti, che dicono di farlo per il bene dei ragazzi mentre in realtà sono impegnati a fare i propri interessi. Noi ci facciamo i nostri comodi da mattina a sera, e se i bambini disturbano’, magari perché hanno paura di un cane per strada, invece di cambiare strada diciamo ‘no, il cane non ti deve far paura, ti sto educando’. Stiamo mettendo a tacere tutte le emozioni dei nostri figli e studenti”.
Quali conseguenze ha questa repressione emotiva?
“Quando tu non puoi esprimere le tue emozioni, mentre ti viene detto che ti amano tanto e ti vogliono tanto bene, anche se in realtà stanno facendo solo i loro interessi, arrivi in adolescenza con un vuoto identitario senza precedenti. Hai dovuto fingere di essere amato, stai cercando questo amore che ti avevano promesso ma non lo vedi, a meno che tu non assecondi i bisogni degli adulti. Incontri insegnanti che ti chiedono di giocare insieme e poi ti sospendono o ti mettono 5 in condotta se esprimi un’opinione. L’adulto fa tutto quello che vuole, ma poi pretende che il figlio sia normato, quando entra a scuola”.
La responsabilità di internet e delle nuove tecnologie
Si dà spesso la colpa a internet e ai social media…
“Dopo aver fatto tutto quello che vogliono, invece di preoccuparsi della scuola, della famiglia, dicono che è colpa di internet – la grande ‘lava coscienza’ della società. Dopo aver disboscato il pianeta, plastificato i mari, reso i giovani più poveri di noi, fatto attraversare loro una pandemia, gli togliamo anche internet a scuola e li perquisiamo a 18 anni. L’emozione non legittimata diventa violenza, e a quel punto diciamo che è colpa dei videogiochi e dei social network. Io dico: videogiochi, zero morti. Gli adulti invece fanno le guerre, causano le tastrofi ambientali. Stiamo confondendo il reale e il virtuale”.
La colpa è sempre cercata altrove?
“Se in Italia ti rubano una borsetta, passi sopra col suv a chi te l’ha rubata, gli adulti dicono che l’assenza del senso di vita e del rispetto dell’altro dipenderebbe dai videogiochi, dove non è mai morto nessuno. Mi dica se non è una dissociazione”.
Come cambiare rotta
Esistono esempi virtuosi da seguire?
“Sono già in Italia, è inutile guardare fuori. Ogni istituto scolastico si muove a proprio modo. Basterebbe seguire i dirigenti scolastici meravigliosi che conoscono su 600 studenti tutto, nome e cognome, e chiedono ogni giorno come va, sanno tutto delle loro famiglie. Dove essere mandati dal preside non è una minaccia ma una promessa”.
I ragazzi come rispondono a questi approcci diversi?
“La cosa incredibile è che oggi questi ragazzi sono espertissimi di relazione, avendo dovuto intercettare i bisogni degli adulti. Quindi basta che trovino un adulto che chieda chi sono e raccontano tutto. Oggi i ragazzi vanno a scuola e seguono gli insegnanti, ma li seguono in nome della relazione, in nome del fatto che sentono che c’è un soggetto che si identifica con loro”.
Il sistema può cambiare?
“Il sistema non cambia. Sono le persone, le relazioni che possono fare qualcosa. Io non critico la scuola, sono per salvarla, e la stanno salvando un sacco di insegnanti che fanno già queste cose qua e le possono fare con l’autonomia scolastica che hanno. Conosco presidi che riescono a trasformare una scuola, ma poi magari vengono trasferiti in un’altra e vengono osteggiati da sindacati e genitori”.
La dissociazione nella società contemporanea
C’è una dissociazione tra ciò che diciamo e ciò che facciamo?
“È una dissociazione tra quello che è il modello di società che proponiamo ogni giorno, con cui bandettiamo e ci arricchiamo, e quello che proponiamo ai giovani. Oggi il presidente del Consiglio parla prima ai social che ad altri canali, il Festival di Sanremo è nato sui social, e poi diciamo che i social faranno male ai ragazzi?”
Come affrontare il cambiamento epocale?
“Le ricerche dicono che due lavori su tre che faranno i bambini che oggi sono alle scuole primarie non sappiamo quali saranno. L’unica certezza è saper usare internet e l’intelligenza artificiale, che noi impediamo di usare solo a loro, perché in università e sul lavoro la usiamo tranquillamente. Se la usano loro, diciamo che stanno copiando”.
Qual è il rischio se non cambiamo?
“Qui sommiamo la denatalità all’esodo dalla scuola e a breve, se questa non diventa il luogo vero degli apprendimenti ma solo il luogo dove devi portare a casa il titolo, non troverà più nessuno. In Italia a un certo punto le caserme hanno chiuso ed è sparita un’istituzione come il servizio militare perché nessuno voleva più partire. In questo momento le università stanno cercando di capire come mai aumentano così le iscrizioni alle università online. Niente è per sempre. Io dico queste cose perché vorrei morire difendendo la scuola pubblica italiana, perché un adolescente che non è a scuola ed è disperso è in un posto peggiore: o è in casa, e in casa non devi stare con la famiglia in adolescenza, o è in una casa circondariale, o è in una comunità, o è in una neuropsichiatria”.
Consigli pratici per insegnanti
Cosa possono fare concretamente gli insegnanti per essere più efficaci con gli adolescenti di oggi?
“Prima di tutto, partire dalle domande dei ragazzi, non fare loro le domande. Le domande servivano ai tempi in cui nessuno aveva le basi del sapere, oggi serve fare le domande giuste per costruirsi un futuro. Poi valutare in modo qualitativo, spiegando dove si è sbagliato e come migliorare, non limitandosi a dare un voto. È fondamentale costruire una relazione autentica: chiedere chi sono, mostrare interesse reale per le loro vite”.
E riguardo all’uso della tecnologia?
“Invece di demonizzarla, usarla come strumento. Gli insegnanti più innovativi fanno fare compiti con l’intelligenza artificiale, creano percorsi interdisciplinari, insegnano il pensiero critico più che la memorizzazione. Non ha senso perquisire i ragazzi per trovare cellulari quando tutta la società è digitalizzata. Piuttosto, insegniamo a usare questi strumenti in modo consapevole”.
Come gestire le emozioni in classe?
“Bisogna dare spazio a tutte le emozioni, non solo quelle ‘positive’. Se un ragazzo esprime rabbia o tristezza, non va zittito ma ascoltato. Molti insegnanti efficaci creano momenti di confronto in cui si può parlare liberamente, senza giudizio. La rigidità e l’autorità non funzionano più, serve una autorevolezza basata sulla competenza e sulla capacità di entrare in relazione”.
Qual è la sua conclusione?
“La scuola è uguale identica a quella di Gentile, sono tutte pseudo riforme. Il tema di base è che non serve più a niente l’apprendimento dall’alto al basso. Hai ancora una scuola dove l’insegnante va e ti racconta cosa lui sa e tu gli devi restituire quello che ti ha detto – una cosa assurda. Le stesse informazioni uno le trova su internet quando vuole. È cambiato tutto, ma la scuola è rimasta ferma. Chi difende la vecchia scuola italiana, con i cinque in condotta, le bocciature, i tre, sta scherzando col fuoco, perché rischiamo davvero che i ragazzi la abbandonino del tutto”.