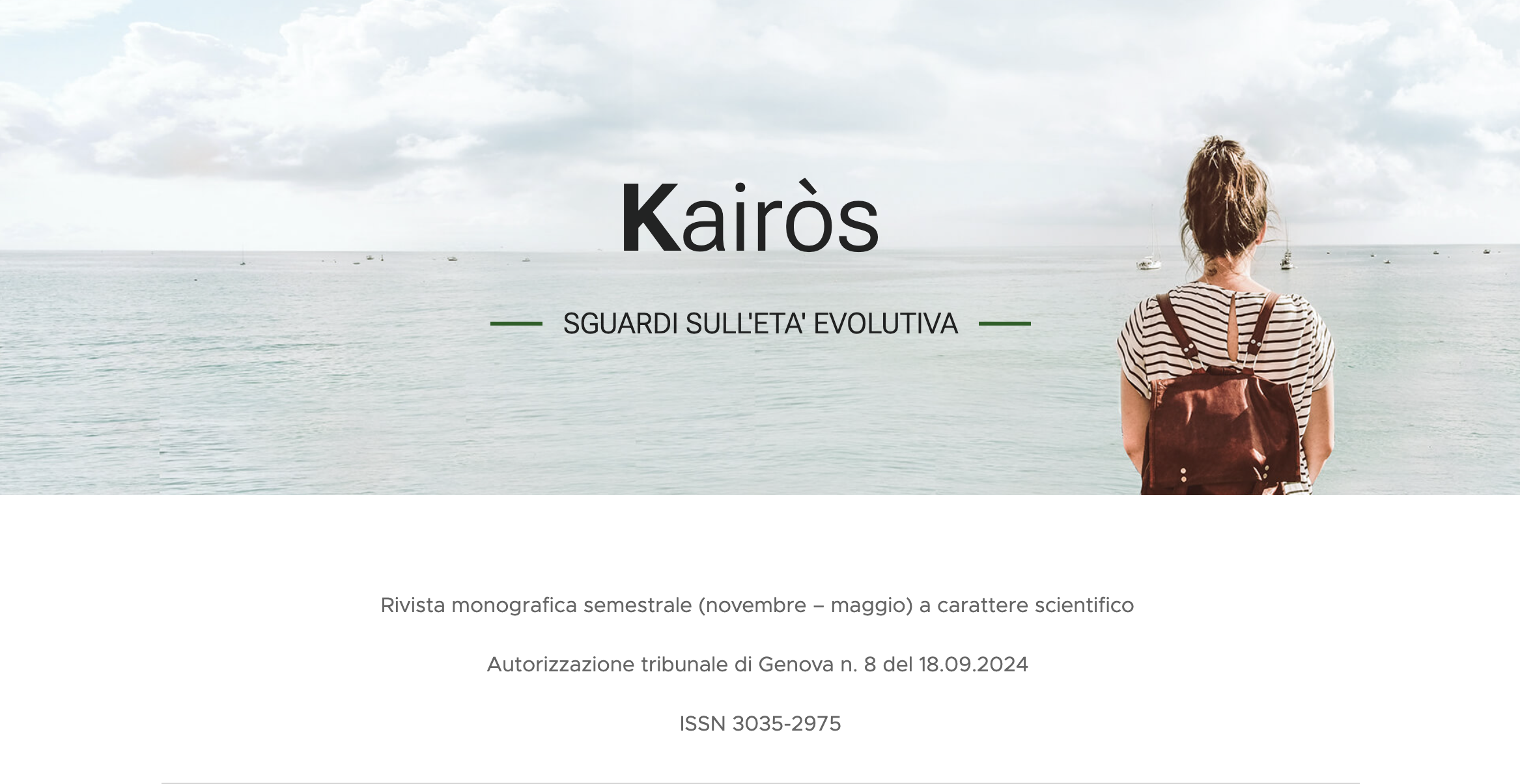N. 2/2025 – Rifugi della mente
(S. Baroni, S. Carboni, S. Fusi, A. Marcazzan, Z. Mehrnoosh, S. Messina, E. Regis, R. Rolla, R. Rota )
Abstract
L’autolesionismo adolescenziale è un fenomeno complesso e in crescita, che riflette le sfide emotive e relazionali affrontate dagli adolescenti nella società contemporanea. Questo comportamento, che include atti di violenza inflitti al proprio corpo, emerge spesso come risposta a un profondo malessere interiore e a difficoltà nella costruzione dell’identità. Le dinamiche familiari, le relazioni sociali e le pressioni culturali, come gli ideali di bellezza irrealistici, giocano un ruolo cruciale nell’insorgere di tali comportamenti. L’articolo esplora come l’autolesionismo possa fungere da meccanismo di coping, esprimendo conflitti emotivi che non trovano altre modalità di comunicazione. In questo contesto, l’autolesionismo è visto non solo come un segnale di crisi, ma anche come un’opportunità per comprendere e affrontare le fragilità dell’adolescenza.
Parole chiave
Autolesionismo, corpo, identità, adolescenza
Autrici
Sara Baroni, psicologa e psicoterapeuta, è socia dell’Istituto Minotauro di Milano. Svolge consultazioni con preadolescenti, adolescenti e giovani adulti e interventi di supporto al ruolo genitoriale. Si occupa di ricerca e formazione, con interesse per le tematiche del corpo, dell’identità di genere in adolescenza.
Alessandra Marcazzan, psicologa e psicoterapeuta, è socia dell’Istituto Minotauro di Milano, dove svolge consultazioni con preadolescenti, adolescenti, giovani adulti e con i loro genitori. E’ docente presso la Scuola di psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro. Si occupa di ricerca e formazione, interessandosi principalmente ai temi dell’immagine corporea e degli attacchi al corpo. Tra le sue pubblicazioni: Piercing e tatuaggio. Manipolazioni del corpo in adolescenza, con G. Pietropolli Charmet, Franco Angeli, 2008.
IL SIGNIFICATO PROFONDO DEI GESTI AUTOLESIONISTICI IN ADOLESCENZA
L’autolesionismo adolescenziale rappresenta un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante, caratterizzato da atti di violenza inflitti al proprio corpo, come tagliarsi, bruciarsi o procurarsi altre forme di danno fisico. Questi comportamenti tendono a manifestarsi con maggiore frequenza durante la pubertà, con una prevalenza significativamente più alta tra le femmine rispetto ai maschi. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia circa il 20% degli adolescenti si è ferito volontariamente almeno una volta, con un picco di incidenza tra i 13 e i 15 anni. Tuttavia, la natura privata di questi gesti, spesso celati dal segreto, rende difficile ottenere dati precisi sulla loro diffusione. Le stime, comunque, suggeriscono un aumento costante del fenomeno, alimentato dalle difficoltà emotive e relazionali che caratterizzano l’attuale generazione di adolescenti.
Gli agiti autolesivi sono modi in cui l’adolescente comunica un malessere profondo, cercando nel dolore fisico un sollievo temporaneo per un dolore emotivo, percepito come insostenibile. Durante l’adolescenza, infatti, il corpo diventa lo strumento privilegiato per esprimere vissuti che la mente fatica ad organizzare in pensieri e a verbalizzare. I cambiamenti che segnano l’ingresso nella pubertà attivano trasformazioni significative sia a livello corporeo che psicologico: il corpo non è più un semplice “contenitore” neutro, ma diventa il palcoscenico su cui si rappresenta il proprio Sé.
La costruzione dell’identità adolescenziale è un processo complesso e multifattoriale, influenzato da molteplici variabili sia psicologiche che sociali e culturali. In particolare, la qualità delle relazioni affettive durante l’infanzia riveste un ruolo cruciale nello sviluppo dell’autoefficacia e dell’immagine corporea. Un attaccamento sicuro, caratterizzato da interazioni positive e da un supporto emotivo adeguato, favorisce una percezione positiva di sé e una migliore regolazione emotiva. Al contrario, esperienze di abuso o trascuratezza possono compromettere la capacità di autoregolazione e portare a comportamenti autolesionistici come espressione di un disagio psichico (Gargiulo e Margherita, 2014).
Tuttavia, non sono solo queste situazioni a costituire un fattore di rischio per l’esordio di comportamenti di attacco al corpo. Negli ultimi decenni si è assistito a un cambiamento nelle modalità di accudimento e cura dell’infanzia, che ha enfatizzato le potenzialità del bambino, rivelando al contempo la fragilità degli adulti (Lancini, 2023). Oggi, il bambino si trova spesso al centro di relazioni affettive altamente rispecchianti e a basso conflitto, configurazioni che, pur risultando nutrienti, possono rivelarsi inadatte a sostenere il processo evolutivo di separazione e individuazione, cruciale in adolescenza. L’idealizzazione delle relazioni affettive porta talvolta gli adulti a evitare i conflitti e a educare il bambino secondo un’ideologia che nega la dimensione pulsionale, vista come una minaccia al legame. Questo atteggiamento può indebolire la spinta verso la ricerca di nuovi oggetti di investimento e, più in generale, la possibilità di accedere ad esperienze non familiari, che strutturano e convalidano il nascente Sé adolescenziale. Ricerche internazionali indicano che l’iper-accudimento genitoriale è correlato a una forte ansia nei ragazzi, influenzando negativamente il loro rapporto con l’altro e con la sessualità (Twenge, 2018).
La pubertà segna l’inizio di un processo di separazione, che implica una rinegoziazione di confini e distanze relazionali. In questa fase, il corpo assume un significato simbolico centrale, diventando il fulcro di cambiamenti che riflettono ed enfatizzano le trasformazioni del Sé. Mentalizzare il corpo, ovvero attribuire significato e valore non solo alle sue forme, ma anche ai nuovi bisogni e alle nuove relazioni, è il compito prioritario di questa fase della crescita. Si tratta di un processo in cui la difficoltà di integrare le sensazioni e le percezioni del corpo con i vissuti interni, può generare nell’adolescente un senso di confusione e di ansia. Il corpo può essere vissuto come una parte estranea del sé e, a partire da questa rappresentazione, viene spesso esposto al rischio, danneggiato o attaccato.
In questa delicata fase, caratterizzata da una fisiologica fragilità narcisistica e dalla costante ricerca di conferme, il contesto socio culturale esercita una forte pressione sugli adolescenti. Gli ideali di bellezza irrealistici e gli standard corporei normativi, diffusi dai media e dai social network, accentuano il divario tra l’immagine reale e quella idealizzata, alimentando sentimenti di vergogna. La dissonanza tra le immagini di corpi perfezionati dalla dieta, dal fitness e dalla cosmesi, proposti sui social e la percezione della propria inadeguatezza, mortificano il nascente Sé adolescenziale. L’insoddisfazione per le forme e le proporzioni del corpo concretizza un più profondo sentimento di angoscia, e può contribuire a provocare i comportamenti autolesionistici come meccanismi di coping maladattivi.
I tagli, le cicatrici non sono solo segni fisici, ma simboli di una lotta interiore volta a trovare un equilibrio tra aspetti problematici ma reali del Sé e un ’immagine ideale, irraggiungibile. L’autolesionismo può rispondere sia al bisogno di punire il corpo, percepito come responsabile della sofferenza, sia al desiderio di riappropriarsene per affermare la propria esistenza. Il dolore fisico provocato dai tagli, dalle bruciature o da altri attacchi al corpo può rappresentare un modo per “sentirsi vivi”, contrastando l’angoscia del vuoto e della solitudine. In questo senso, il gesto autolesivo assume una doppia valenza: da un lato, esprime il tentativo di riprendere il controllo di un corpo vissuto come estraneo; dall’altro, diventa un mezzo per imprimere sulla pelle sentimenti e aspirazioni.
In molti casi, l’autolesionismo è un atto solitario, nascosto, che serve come meccanismo per gestire un dolore troppo intenso per essere espresso verbalmente. In questo senso, i tagli degli adolescenti, pur indicando una condizione di grave malessere che richiede un intervento tempestivo e mirato, possono avere una valenza protettiva rispetto a condotte più estreme e al rischio suicidale.
Le dinamiche relazionali, sia familiari che sociali, sono spesso intrecciate con il fenomeno dell’autolesionismo. La famiglia, la scuola e il gruppo dei pari giocano un ruolo fondamentale nella formazione dell’identità adolescenziale. Le difficoltà relazionali in questi ambiti, come conflitti familiari, difficoltà scolastiche o la mancanza di supporto emotivo, possono quindi contribuire all’insorgere di questi comportamenti. In questo senso, le risposte degli adulti e dei pari alla scoperta del gesto autolesivo possono influire significativamente sull’evoluzione del comportamento. Un ascolto empatico e attento, privo di giudizio, può rappresentare una risorsa fondamentale per aiutare l’adolescente a rielaborare il proprio dolore e trovare altre modalità per affrontarlo.
Il caso di Anna
Anna ha 13 anni, frequenta la terza media. Dalla prima media però Anna vive una situazione molto difficile sul piano scolastico, che l’ha portata a soffrire di attacchi di panico e a compiere gesti autolesivi.
Quando incontro i suoi genitori per un primo colloquio riferiscono di Anna come di una ragazza intelligente, curiosa ma anche sportiva. Anna invece fatica molto nelle relazioni: non è stata fortunata alle elementari, e alle medie le cose sono andate, se possibile, peggio. In prima media Anna ha sofferto di un disturbo alimentare restrittivo: la comparsa del ciclo aveva scatenato in lei vissuti di profonda angoscia, collegati sia alla possibilità di vedere il proprio corpo cambiare, assumendo forme incompatibili con l’immagine esile e atletica, richiesta dallo sport che praticava, sia provocati dal confronto con compagne di classe che utilizzavano il nuovo corpo femminilizzato come oggetto di una competizione spietata, rispetto alla quale Anna si sentiva totalmente impreparata. L’avvio di una presa in carico psicologica e anche il trasferimento in una nuova scuola, avevano permesso di risolvere nel giro di qualche mese il sintomo alimentare.
L’anno successivo Anna si era innamorata e aveva cominciato a frequentare un ragazzo della scuola più grande di lei di un anno. Inizialmente i genitori, vedendo Anna felice e avendo conosciuto Andrea, erano contenti di questa relazione: il ragazzo era ben educato e premuroso nei confronti di Anna. Si vedevano a scuola, qualche volta di pomeriggio e poi, come spesso capita, stavano sempre insieme al telefono. La mamma aveva riferito che ad un certo punto, in primavera, aveva visto Anna cambiare bruscamente: avevano sempre avuto tra loro un rapporto di vicinanza e improvvisamente la ragazza si era fatta più taciturna. Sembrava sempre alle prese con le chat e le chiamate che riceveva sul cellulare, e si era via vita ritirata nella sua cameretta. I genitori avevano anche notato una tristezza, un’inquietudine crescente, si erano spinti a chiederne le ragioni ad Anna senza ottenere grandi risposte. Poi era comparsa l’ansia e anche gli attacchi di panico: Anna era riuscita a raccontare di trovarsi in grande difficoltà con Andrea che le chiedeva di non dare confidenza ai suoi compagni di classe maschi e di non fidarsi troppo neanche delle ragazze, che spesso parlavano male di lei. Anna era convinta che Andrea le dicesse queste cose per proteggerla ma poi in classe si sentiva terribilmente isolata e persa.
I genitori erano intervenuti parlandole del fatto che Andrea non dovesse condizionare le sue relazioni e le avevano vietato di frequentarlo. I due ragazzi però avevano continuato a vedersi a scuola e Andrea aveva cominciato a criticare apertamente i genitori di Anna, il fatto che impedissero alla loro storia di crescere. Anna aveva iniziato a sentirsi insofferente nei loro confronti, arrabbiata, confusa. Un pomeriggio la mamma aveva visto sulle braccia della figlia delle cicatrici e aveva così scoperto che si tagliava. Questo le aveva permesso di riavvicinarsi a lei, per parlarle di quanto la vedeva sofferente negli ultimi mesi.
I tagli, che Anna si procurava dall’inizio della conflittualità con i suoi genitori, erano diventati poi il modo in cui esprimeva tutta la sua angoscia a fronte delle pressioni e delle limitazioni imposte da Andrea. Alla fine della terza media i genitori di Anna erano riusciti a convincerla a lasciarlo. Dopo un’estate terribilmente triste e vissuta in una solitudine estrema, Anna ricomincia la terza media in grande fatica sia con i compagni di classe, con i quali l’anno precedente non ha costruito nessun legame, sia con i professori, che hanno interpretato le sue crisi d’ansia come richieste di attenzione eccessive e faticose da gestire. I tagli si ripresentano a casa e a scuola nei momenti in cui Anna si sente sovrastata da troppe emozioni. È solo a fronte di questa nuova crisi che i genitori si attivano e Anna arriva nel mio studio.
Il lavoro con lei ci permette di cercare il significato di questi tagli, che hanno svolto funzioni differenti: se all’inizio la aiutavano soprattutto ad agire la sua rabbia nei confronti dei genitori, successivamente erano diventati un modo di tenere a bada vissuti claustrofobici causati dalle limitazioni proposte dal giovane fidanzato. Negli ultimi mesi, i tagli però erano diventati una sorta di risposta passe-par-tout nelle situazioni di sovraccarico emotivo, quelle in cui anche il pensiero finiva per confondersi. I tagli, come comportamento ricorsivo, erano in grado di riportare benessere, di porre fine all’ansia e al discontrollo con un gesto che rompeva il flusso emotivo e rimetteva al centro la concretezza del corpo ferito.
Narrare la sua storia, ha permesso ad Anna di mettere a fuoco alcuni temi. Primo fra tutti quello della relazione con un corpo che era stato vissuto in preadolescenza come portatore di nuove forme ma anche di significati che rompevano con le rappresentazioni precedenti di Sé: l’attacco al corpo, inizialmente giocato attraverso il sintomo alimentare restrittivo, sembra rivolto soprattutto ai processi di trasformazione del corpo infantile.
I sintomi autolesivi, così come gli attacchi di panico, fanno pensare a caratteristiche specifiche assunte dal corpo come luogo di scarico delle tensioni e dei conflitti interni: si tratta di un corpo che assume la funzione di dare voce e concretizzare emozioni altrimenti indicibili.
Un altro dei temi trattati con Anna è quello relativo al difficile avvio del suo processo di separazione dai suoi genitori: la mancata identificazione con il gruppo femminile alla fine delle elementari; il fallimento nella scelta di un nuovo oggetto d’amore, sono tutti elementi che concorrono a far sentire Anna che è impossibile separarsi.
In preadolescenza la costruzione di relazioni amicali e, talvolta, la sperimentazione dei primi legami amorosi, consentono un sostegno affettivo che risulta essenziale per allentare il legame di dipendenza dai propri genitori: allora i tagli nella storia di Anna simbolicamente possono essere letti come dichiarazioni di rottura, bisogni di apertura.
In questa situazione è stato fondamentale il lavoro di sostegno al ruolo genitoriale, volto soprattutto ad una negoziazione delle distanze reciproche e alla possibilità di accedere a una rappresentazione di aspetti adolescenziali inediti nella figlia.
Inoltre, è stato utile parlare con la scuola per presentare la situazione di Anna e per affrontare la difficoltà dei docenti combattuti tra una lettura esibizionistica dei gesti e la comprensione della sofferenza della ragazza.
Anna ha gradualmente recuperato le relazioni con i compagni e gli insegnanti e si sta preparando alla scelta della nuova scuola, con i timori e le speranze tipiche di questo passaggio. Ha smesso di tagliarsi anche se sente di dover ancora fare un pezzo di strada insieme, per essere sicura di non tornare a farlo.
Conclusioni
L’autolesionismo adolescenziale non è semplicemente un comportamento autodistruttivo, ma un tentativo di comunicare un disagio profondo che non riesce a trovare parole per esprimersi. Comprendere i significati sottesi a questi gesti è essenziale per intervenire in modo efficace, evitando di ridurli a meri indicatori psicopatologici, e cercando invece di decifrare il messaggio che il corpo trasmette.
In una fase della vita caratterizzata da profondi cambiamenti fisici, emotivi e relazionali, l’attacco al corpo può essere un tramite per dare forma e voce a sofferenze interne difficili da elaborare. Capire il senso di questi gesti significa quindi interpretare una richiesta d’aiuto che, se ascoltata con attenzione, può condurre l’adolescente ad esplorare il proprio mondo interno e a trovare in esso le risorse per superare il dolore che lo ha spinto a farsi del male.
Nella nostra esperienza di lavoro, gli interventi terapeutici che adottano una prospettiva multifocale e valorizzano le risorse del contesto, sono quelli che offrono migliori prospettive prognostiche e di ripresa evolutiva.
Bibliografia
American Psychiatric Association (2014), DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015.
Anzieu D. (1987), L’Io pelle, Borla, Roma, 2015.
Bick, E. (1968), L’esperienza della pelle nelle prime relazioni oggettuali, in Isaacs S., L’osservazione diretta del bambino, Bollati Boringhieri, Torino, 1989.
Di Agostino C., Fabi M., Sneider M. (2016), Autolesionismo. Quando la pelle è colpevole, Asino D’oro edizioni, Roma
Gargiulo A., Margherita, G. (2014), “Autolesività non suicidaria e genere: rassegna teorica e riflessioni psicodinamiche”, Infanzia e Adolescenza, 13, 2: 119 128. DOI: 10.1710/1624.17656.
Jeammet P. (1980), Psicopatologia dell’adolescenza, Borla, Roma, 1992.
Lancini M. (2023), Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta, Cortina, Milano.
Lingiardi V., McWilliams N. (a cura), PDM-2. Manuale Diagnostico Psicodinamico, Raffaello Cortina Editore, 2018.
McWilliams N. (1994), La diagnosi psicodinamica. Struttura della personalità e processo clinico. Astrolabio, Roma, 2006.
Menninger K.A. (1938), Man against himself, Harcourt, Brace e World, New York.
Mucci C. (2020), Corpi borderline. Regolazione affettiva e clinica dei disturbi di personalità, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Muehlenkamp J. J., Brausch A. M. (2011), “Body image as a mediator of non-suicidal self-injury in adolescents” Journal of Adolescence, 35(1):1-9. doi.
OMS (2018), World Health Statistic, Monitoring health for the SDGs.
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (2022), Un caso al giorno negli ultimi due anni tra tentativi e ideazioni di suicidio tra i giovanissimi, Testo disponibile al sito: https://www.ospedalebambinogesu.it/un-caso-al-giorno-negli-ultimi-due-anni-tra-tentativi-e-ideazioni-di-suicidio-tra-i-giovanissimi-143061/
Rossi Monti M., D’Agostino A. (2009), L’autolesionismo, Carrocci, Roma.
Schore A.N., (2003), La disregolazione degli affetti e la riparazione del sè, Astrolabio, Roma, 2008.
Siegel D.J. (2013), La mente adolescente, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014.
Suyemoto K. L.,MacDonald M. L. (1995), “Self-cutting in female adolescents” Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 32(1), 162–171.
Townsend E., Ness J., Waters K., Rehman M., Kapur N., Clements C., Geulayov G., Bale E., Casey D., Hawton K. (2022), “Life problems in children and adolescents who self-harm: findings from the multicentre study of self-harm in England”, Child and Adolescent Mental Health, 27(4):352-360.
Twengee J. M.(2018), Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a diventare adulti, Einaudi, Torino, 2018.
Van der Kolk B. A., Perry J. C., Herman J. L. (1991), “Childhood origins of self-destructive behavior” American Journal of Psychiatry, 148(12):1665-71.