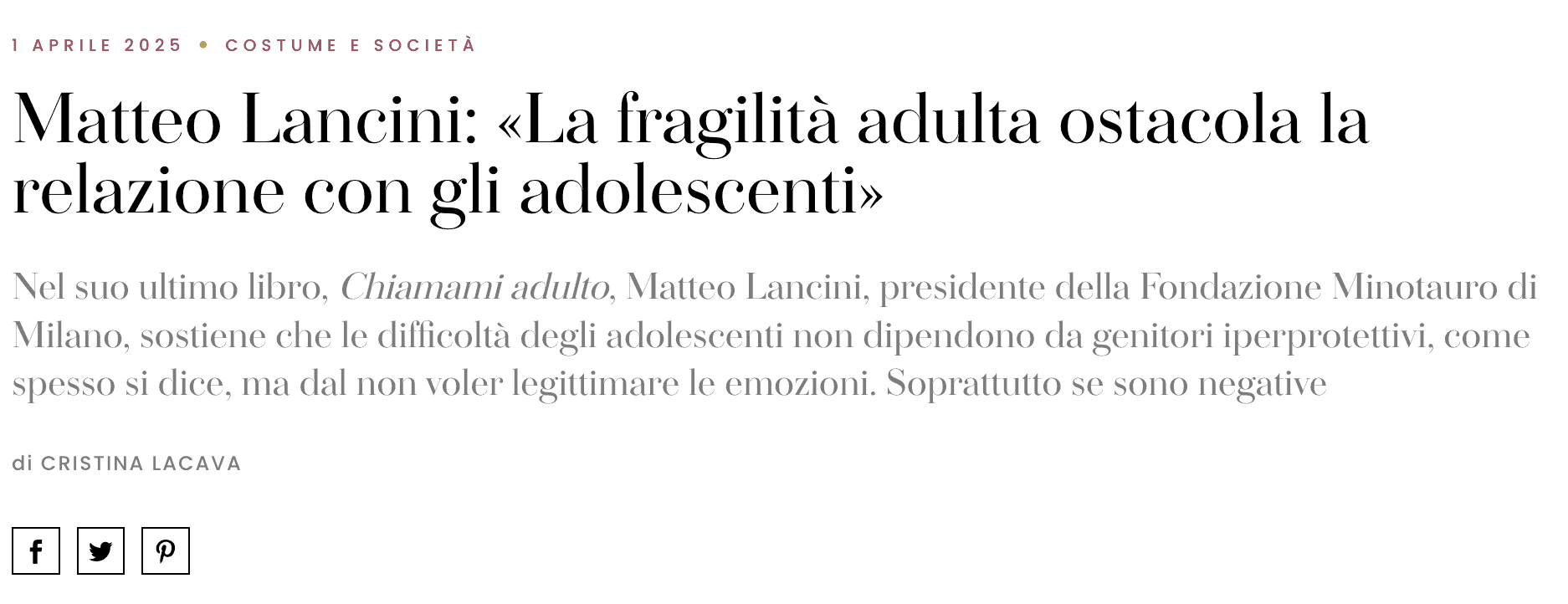Matteo Lancini: «La fragilità adulta ostacola la relazione con gli adolescenti»
di Cristina Lacava
Nel suo ultimo libro, Chiamami adulto, Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, sostiene che le difficoltà degli adolescenti non dipendono da genitori iperprotettivi, come spesso si dice, ma dal non voler legittimare le emozioni. Soprattutto se sono negative
Ragazzini che ammazzano coetanei per una felpa non pagata, o che infieriscono sui familiari senza un motivo, almeno apparente. E una serie tv, Adolescence, che ci sbatte in faccia una scomoda realtà: adolescenti e adulti non si capiscono, sono due mondi separati. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, sostiene che il problema non è l’iperprotezione ma la mancanza di una relazione autentica tra le generazioni. Una relazione che gli adulti fragili di oggi non riescono a sostenere. Una tesi controcorrente al centro del suo ultimo libro, Chiamami adulto (Raffaello Cortina editore). Ne abbiamo parlato insieme.
Dice all’inizio del libro che la relazione è tutto. Che cosa significa?
La relazione allunga la vita e fa prevenzione, soprattutto in una società performante come la nostra dove si chiede di fare, più che di essere. L’unica cosa che può avvicinarsi alla felicità è avere una relazione autentica con qualcuno. Penso che non ci sia mai stata una generazione di adolescenti che ricerchi così tanto una relazione autentica con l’adulto. Non a caso, quando incontrano insegnanti in grado di ascoltarli davvero, i ragazzi raccontano loro delle cose private che mai in passato si sarebbero sognati di raccontare.
Lei però ritiene che sia molto difficile costruire questa relazione. Perché?
Gli adulti sono fragili, e contraddittori nelle richieste che fanno ai figli. Una volta c’era una specie di mandato verticale, per il quale mio nonno diceva a mio padre: devi fare dei figli e devi lavorare. Noi abbiamo cambiato tutto e diciamo a questi figli, che facciamo meno e sempre più in là nel tempo, che sono figli voluti. Facciamo loro una promessa d’amore, fin dalla più tenera età. Poi però noi non la manteniamo, quando i figli ci rompono le scatole. Chiediamo ai figli di essere se stessi a modo nostro, non gli facciamo mai la domanda che dovremmo fare: chi sei tu?
E quando ci rompono le scatole?
Quando esprimono emozioni che ci disturbano, in particolare la paura, la tristezza e la rabbia. Emozioni che gli adulti hanno bandito completamente in una società basata sulla visibilità e la popolarità. Siccome sono fragili, e non in grado di sostenerle, rompono il patto. Se un bambino incontra un cane che gli fa paura, la madre invece di cambiare strada gli dice che il cane è buono, e lui non deve averne paura. Risultato: il bambino si terrà la sua paura per sé. Oppure, si va a una festina con il clown e il bambino dice: mi intristisce. La mamma gli risponde che non deve essere triste, non legittima la sua emozione. Anzi, aggiunge che se continua finirà per essere escluso dal gruppo e dovrà andarsene dalla festa. Così lei non potrà prendere l’aperitivo con gli altri genitori.
Quindi non è vero che la causa del disagio giovanile è l’iperprotezione dei genitori, che danno tutto, e troppo, ai figli?
No, è solo una favoletta che non rende conto di quel che vediamo da anni: le emozioni non vengono legittimate. Non è vero che i genitori fanno fare tutto ai figli, è vero il contrario. Noi facciamo quello che vogliamo. Ci troviamo con ragazzi che esplodono in adolescenza, perché le emozioni che ci disturbano sono necessarie alla costruzione della loro identità, e noi non le accettiamo.
Secondo lei, Matteo Lancini, quali errori fanno i genitori?
Il problema è che organizzano una vita perfetta ai figli, fatta di esperienze in cui non devono farsi male. Gli sequestrano il corpo. Altro che iperprotezione, così continuano a farsi gli affari propri. Se impari a nuotare, al mare non ti devo seguire e posso stare a prendere il sole. Si legittima se stessi dicendo che lo fai per gli altri. Invece dobbiamo tornare a riconoscere i bisogni dei nostri figli studenti. La disperazione giovanile dipende da questo, ci facciamo i fatti nostri e non rispettiamo quel patto iniziale. Un bambino che nasce con quel patto si aspetta di essere amato per quello che è. Noi invece mettiamo a tacere le sue emozioni creando un vuoto identitario.
Altro tema importante, la scuola. Le nuove regole sul voto in condotta – si viene bocciati con il 5, sotto il 9 non si può avere il voto massimo all’esame di maturità- serviranno a restituire autorevolezza all’istituzione?
Due schede su tre che arrivano al Minotauro sono di ragazzi intelligenti che non vogliono più studiare. Il sistema è organizzato dagli adulti, che invece di accettare il malessere dei ragazzi tornano a una scuola vecchio stampo con l’idea che i ragazzi non stanno alle regole perché sono trasgressivi o oppositivi. C’è un problema importante di abbandono. E non è colpa di internet, ma di un’offerta che guarda solo agli adulti. Esistono tantissime sperimentazioni che dimostrano che una valutazione non numerica è la più rigorosa. Gli insegnanti più bravi non danno un voto numerico, perché quello orienta gli studenti solo al risultato, non li spinge a voler apprendere. Dare il 5 in condotta o le valutazioni numeriche vuol dire fregarsene di favorire gli apprendimenti. All’università si lavora con l’AI, se lo fanno a scuola li chiamiamo copioni. Tutti sono connessi, soprattutto gli adulti, noi ai ragazzi di non farlo. E continuiamo a fare la scuola come ai tempi di mia nonna.
Nella serie tv su Netflix Adolescence è evidente come i due mondi, adulti e ragazzi, sono separati.
La cosa più terribile è che non c’è un adulto significativo in quella serie. Non è un problema solo della scuola, c’è un’inconsistenza degli adulti senza precedenti. I figli in difficoltà si imbarazzano – penso al figlio del poliziotto – e consolano i genitori.
Un libro di grande successo, La generazione ansiosa di Jonathan Haidt, dà tutta la colpa a internet. Ma lei, Matteo Lancini, non è convinto.
Oggi i ragazzi stanno male e vanno su internet, non è internet la causa del disagio. Ma è più facile pensare che noi li amiamo troppo e il disagio è colpa di internet piuttosto che pensare che i ragazzi stanno male e vanno su internet per cercare di risolvere i loro problemi. Quel libro è un’ottima testimonianza di quel che sta succedendo: gli adulti confondono il reale col virtuale, sostengono che la violenza giovanile dipende dai trapper o dai videogiochi violenti e non dalla realtà, da guerre con bambini morti o dal fatto che se ti rubano una borsetta passi cinque volte con il Suv sopra il corpo del ladro, tanto dei morti veri non ce ne frega niente. Dici che il valore dell’altro non conta, ed è giusto che tu passi col Suv cinque volte sul corpo di un ladro e pazienza se i bimbi muoiono per una guerra di adulti. Poi però sostieni che i ragazzi sono violenti per colpa di un videogioco: è una costruzione dissociata tra realtà e virtualità.